
La grande profondità dei suoi testi e la raffinata ricerca sul suono rendono Marco Momi uno dei compositori di spicco della sua generazione. Nato a Perugia nel 1978, studia pianoforte, direzione d’orchestra e composizione a Perugia, Strasburgo, L’Aja, Roma, Darmstadt e Parigi. Premiato in numerosi concorsi internazionali, quali il Gaudeamus Music Prize e la Seoul International Competition, è stato compositore in residenza presso l’Akademie der Künste di Berlino e l’American Academy in Rome. Il suo nome compare nella programmazione dei maggiori festival, quali Musica Strasbourg, ManiFeste Paris, Wittener Tage für neue Kammermusik, Milano Musica e Biennale di Venezia, eseguita da Ensemble Intercontemporain, Nikel, Klangforum Wien e Neue Vocalsolisten Stuttgart, tra gli altri. Per Obiettivo Contemporaneo affrontiamo alcuni dei temi centrali del suo fare musica, dal concetto di scenarizzazione, al ruolo della scrittura e dell’interpretazione, con particolare attenzione alla sua produzione per chitarra e al rapporto col chitarrismo.
Un elemento che caratterizza gran parte della tua produzione è l’affiancamento a strumenti acustici dell’elettronica – generalmente di sintesi e in tempo differito. Come instauri una narrativa tra queste due dimensioni percettive, che ruolo svolge l’elettronica nel dialogo con lo strumento e qual è il rapporto che cerchi tra fonte acustica ed altoparlante?
La questione della narrativa implica molteplici discorsi. Uno di questi è legato agli attori in scena. Negli ultimi anni ho lavorato molto su un concetto definibile come scenarizzazione – ovvero composizione di scene, attorialità, definizione di valori attanziali. Si tratta di un percorso di consapevolezza del potenziale narrativo che si è sviluppato di pari passo con la necessità compositiva di lavorare con elementi come la connotazione linguistica degli strumenti acustici o elettronici e con le potenzialità di ridefinizione organologia degli stessi (pensiamo semplicemente al ruolo degli attuatori nell’elettronica di oggi o alle preparazioni strumentali). Il cambiamento delle tecniche di emissione e proiezione del suono che ne derivano chiamano a delle scelte narrative tout court. Però separerei questo argomento dalla questione dell’elettronica che nel mio caso va funzionalmente capita come può essere capito un violino – il parlarne a parte invece ne orienta sempre la riflessione in termini di esclusività rispetto alla componente acustica.
Riguardo al rapporto tra le fonti, dal mio punto di vista e allo stato attuale — a cui sono arrivato negli ultimi dieci anni — è effettivamente paritetico. Per cui possiamo in molti casi partire da una riflessione opposta, cioè su qual è il ruolo strumentale all’interno dell’elettronica, anziché sul ruolo dell’elettronica all’interno della realtà strumentale. Su questo, ricordo che già nel 2010 mi piacque starci sopra col cervello per Iconica IV, in cui in un movimento, quello che mi ero proposto di fare era un gioco di inversione di ruoli in cui la parte acustica equalizzasse l’elettronica.
Io non faccio musica elettronica pura, non farò mai musica acusmatica. Feci un’installazione per l’Akademie der Künste di Berlino ma la tolsi dal catalogo. Questo per dire che non lavoro sui materiali della ricerca dell’elettronica, perché semplicemente non mi interessano. Quello che a me interessa è lo spazio in cui l’elettronica entra in frizione o in contatto con i valori identitari acustici, e quindi evidentemente anche, dal punto di vista strettamente frequenziale, la condivisione in uno spazio acustico di irradiamento sonoro. Questo implica tutta una serie di situazioni che, con il passare degli anni, mi hanno portato lontano da quel concetto di sintesi – sviluppato meravigliosamente da molte mie colleghe e colleghi – molto selettivo e concentrato, riferibile a sviluppo di modelli matematici o di programmazione, codici, ottimizzazione, contatto continuo con le macchine, e così via. A me interessa una combinazione tra le mie sintesi e lo sporco, perché è in questo spazio liminale che molto spesso si entra in contatto con la musica mista, almeno nel mio caso.
Dico le sintesi – molte sintesi – perché quello che faccio in termini di elettronica è una moltiplicazione estrema delle fonti e della natura natura dei suoni stessi. Quasi mai ho uno o due bei suoni che compongono un momento musicale, piuttosto ne ho dai 60 ai 250 nell’istante, per cui c’è una composizione riferibile al concetto di stratificazione di molteplicità acustiche. Questo è importante capirlo per non fraintendere la mia elettronica come elettronica tout court, c’è molta orchestrazione e c’è una composizione dell’interazione con interpreti nei miei tape.
In che modo cambia, se cambia, il rapporto strumento-altoparlante nell’uso di uno strumento elettrico piuttosto che acustico, come ad esempio nel caso dei Quattro Nudi per chitarra elettrica ed elettronica? Puoi parlarci della genesi di questo brano?
Chiaramente cambia. Devo dire, nel caso di Quattro Nudi, non ho fatto un particolare lavoro dal punto di vista della diffusione delle sorgenti. Il pezzo era stato commissionato da Christelle Séry ed alcuni centri di ricerca francesi (Why Note, Césaré, GMEA, La Muse en Circuit). Generalmente, se accetto un progetto, mi piace scrivere per gli interpreti, quindi avere un rapporto rispetto a quello che loro stessi hanno, come lavorano, com’è la loro chitarra elettrica, e così via. E questo è stato; per cui dal punto di vista del setup non c’è molto di rivoluzionario.
Quello che c’è di particolare, di chiaramente definito, è la prossimità delle due sorgenti left-right rispetto al posizionamento centrale del cabinet. Questo perché, sia in Quattro Nudi, ma anche in Sans Dire e in altri miei lavori per strumento solo ed elettronica, quello che mi piace toccare è il momento di aumentazione o di sfasamento della porzione spaziale dalla quale il suono viene irradiato.
La disposizione delle sorgenti, in termini di distanze, è al confine del 2 più 1 classico con lo strumento amplificato, con un gradiente di prossimità che rende più o meno definito e più o meno scolpito il panorama left-right, o meglio, mid-side. Se fosse troppo largo produrrebbe una percezione della sorgente sonora strumentale moltiplicata, creando una situazione perturbante all’ascolto che non mi piace. Anche in questo senso parliamo di elettroniche come parte di un evento sonoro, a cui appartiene anche la parte acustica performata live. Parliamo però anche di una logica di ascolto stereo, da disco. C’è una scomposizione del mixaggio della parte d’ascolto, e differenti parti vengono date in questo caso a left-right e mid. I gradi di prossimità si possono definire e misurare anche empiricamente – è una questione molto complessa, ci vogliono anni di esperienza e tuttora faccio e scopro cose. Quel piccolo spazio nel quale il mid poi si allarga nel side, si sfilaccia, e c’è una sorta di inizio di denaturazione, di contaminazione della parte acustica, a me piace particolarmente. È uno spazio che va anche cucito nel momento del concerto.
Vi sono invece altre situazioni di chiara ricerca sull’irradiamento. Ho scritto un brano per viola ed elettronica – che non ho ancora mai ascoltato dal vivo – in cui le casse non sono speakers ma nearfield monitor messi volutamente in controfase, e la viola è posizionata circa un metro e mezzo dietro la linea di controfase. Nel progetto Unrisen per lo SmartPianoQuintet, invece, non ci sono altoparlanti ma dieci trasduttori collocati sugli strumenti. Oppure in Almost Close, in cui c’è solo un punto di elettronica mono proveniente dall’interno del pianoforte, la quale viene riamplificata con il pedale di risonanza del pianoforte stesso – lo strumento pianoforte diventa organologicamente una parte di speaker.
Non avevo mai guardato con senso critico le tradizionali strategie di elaborazione, amplificazione e diffusione della chitarra elettrica fino a una nostra conversazione a fine 2021. Fu grazie a quel tuo stimolo che iniziai ad investigare la questione dell’amplificazione sferica che è ora al centro della mia ricerca artistica. Cosa trovi, o trovavi, insoddisfacente in quell’approccio tradizionalmente chitarristico allo strumento in rapporto alla tua cultura di suono?
La cosa che per me è stata sempre difficile con la chitarra elettrica è stato il fatto che la parte di emissione del suono stesso – e questa è una parte strumentale – fosse embedded, intoccabile, chiusa. Non permette editabilità.
Ci sono delle consumate abitudini dei performer di chitarra elettrica che, a mio avviso, tendono ad assumere una logica che io chiamo ‘a preset’, nel senso che c’è un colore dello strumento che è dato da un amplificatore, un cabinet, ecc., poi ce n’è un altro dato da un altro cabinet, un altro da un’altra marca, e così via.
Questo da un lato comporta un chiaro fascino e dall’altro dei riferimenti culturali e linguistici. Pensa a Vampyr!; in termini di scrittura, quel lavoro afferma linguisticamente un collegamento con, ad esempio, Van Halen, e quindi il pezzo porta con sé un valore linguistico molto forte. A me non piace lavorare esclusivamente con una dinamica di new virginity, per cui l’aspetto linguistico è assolutamente presente, pesato e dosato anche in quello che scrivo. Nella chitarra elettrica però questo era schiacciante e soprattutto molto difficilmente controllabile, perché parliamo di strumenti nei quali tu compositore semplicemente non entri.
Questo per me era abbastanza deludente. Una parte di ciò che fa la musica contemporanea, come l’arte contemporanea, è collegato alla ridefinizione del rapporto con la materia. Ogni giorno riscopriamo la materia, ogni giorno siamo sollecitati dalla materia, e quindi ogni giorno la riscoperta della materia ci impone dei nuovi sistemi per toccare la materia, per entrare in rapporto con essa. Mi ha sempre incuriosito il fatto che questa abitudine quotidiana all’investigazione della ridefinizione del suono fosse completamente bandita nella pratica chitarristica elettrica – che ho conosciuto, che adoro, e di cui ho anche goduto. Questo, però, mi dava anche dei problemi di scrittura. Ho cercato di sedermici sopra in Almost Nowhere, in Ludica II, e anche nei Quattro Nudi, dove comunque ci sono dei riferimenti a delle gestualità chitarristiche linguisticamente connotate, però non sono poi del tutto riuscito ad uscirne in termini di suono.
I tuoi brani sono estremamente impegnativi. Non necessariamente dal punto di vista tecnico-strumentale, ma piuttosto per la fisicità, la gestualità e l’attitudine che viene richiesta all’interprete. Vitale alla piena realizzazione della tua musica, molto più che in altra, è la capacità dell’interprete di andare oltre la scrittura, di essere presente, incarnando e vivendo come necessario ogni evento musicale. A questo proposito ti chiedo sia che ruolo occupa l’interprete nella tua musica, sia qual è il tuo rapporto con il virtuosismo (sia pur antieroico).
L’interprete svolge un ruolo centrale. Quello che cerco di scrivere sono testi che rendano aperta la dinamica di valorizzazione. L’atto interpretativo, come io l’ho conosciuto attraverso la musica classica – e come lo conosco tutt’ora – è un atto che di fronte a un testo, almeno nella grande musica, ci pone nuovamente e perennemente di fronte a delle scelte di valorizzazione dei testi e dei co-testi, cioè di quello che sta davanti, di quello che sta a lato, di quello che sta in fondo, e così via. Parlavamo di scenarizzazione, allora utilizziamo questa metafora della scena: immaginiamo personaggi; personaggi con quale luce; quale luce con quale smorfia; quale smorfia con quale tono di voce; il personaggio che gli sta vicino; quanto gli sta vicino e che postura ha; e così via.
Tutto questo chiede fatica, ma attiva un auspicabile e ambizioso valore testuale che spero rimanga. Si tratta di scrivere il ‘come leggere’ spesso per persone analfabete. Chiaramente quello che scrivo non è fatto per vivere nel tempo in cui sono io adesso. Quello che spero con i miei testi è che sopravvivano, e io cerco di difenderli, poi si vedrà.
In definitiva quello che cerco di fare è quello che a me capita ed è capitato con Brahms, Beethoven, Chopin, Schumann – né più, né meno. C’è un legame con i testi che mi spinge ad entrarci dentro, a rimettere in scala i valori. Per questo è impegnativo per i musicisti, perché chiaramente è musica classica, e la musica classica raramente la si fa prendendo un autore con una tecnica sconosciuta e andando in concerto in una settimana. Se a volte lo si fa è perché c’è una prasseologia definita, nella musica contemporanea invece non c’è o quantomeno non del tutto.
Io scrivo musica che è interpretata, su questo non c’è il minimo dubbio. Appunto per questo la mia matita rifiuta tutti quelli che sono instructional pieces e musica performata, nel senso che lascia al performer un ruolo autoriale sul testo. Mi trovo invece molto spesso a parlare di tocco, di impronta digitale, dell’intenzione che precede il fare suono. Queste sono cose che a me interessano molto più rispetto a lasciare a un interprete qualsiasi uno spazio di creatività che vada a definire tempo, note e gestualità.
Durante una cena, a un mio commento su un tuo tratto caratteriale, mi risposi: «beh, dovresti saperlo, l’hai suonata la mia musica», quasi come se la tua persona, la tua vita, fosse inscindibile dalla tua musica, o perlomeno come se ne fosse riflesso. Citando una tua nota di programma, ‘non posso scrivere musica impermeabile’. Vi è una dimensione di necessità nel tuo comporre?
La dimensione di necessità c’è non solo nel mio comporre ma credo nel comporre di molti – c’è una letteratura meravigliosa su questo e io sento di farne parte. Rispetto al mio esserci con i miei testi, ci sono alcune cose da dire. Parto dall’affermazione sull’impermeabilità. Per me non essere impermeabile significa avere un rapporto dinamico con la mia contemporaneità e le mie ore. Non mi interessano le opere di fissità. Questo mi impone una postura di squilibrio con ciò che ho appena scritto. Non sono un compositore seriale, come può essere Sciarrino, Ferneyhough, Saariaho. Io sono un prototipale. La mia natura mi impone generalmente di pormi in uno stato di disabitudine con le cose che faccio. Per me è molto importante concepire la scrittura non come manifestazione di me stesso ma assolutamente l’opposto. La scrittura è una cosa che mi permette di uscire da me stesso, di simulare di essere qualcun altro. È una moltiplicazione. E questo è stato per me una sorta di conquista, perché quando ero giovane, saranno state le pressioni di carriera che tutti noi avevamo, ma c’era questo mito della riconoscibilità e dell’identità. E a me questa cosa non interessa, ho capito poi – non interessa affatto.
Quando hanno cominciato a chiedermi pezzi perché chissà volevano fossero simili, o avessero dei tratti simili agli altri pezzi, o cominciavano a definire stilisticamente la mia musica, questo mi infastidiva enormemente. Per cui molte volte mi sono sottoposto a delle diete forzate e a dei cambiamenti di rotta molto violenti. Ma questo in realtà è un esercizio di alterità, la moltiplicazione dei punti di vista dello scrivibile per me è assolutamente centrale. Mi sono trovato diverse volte a star male, a scrivere delle cose completamente lontane dal mio sensibile, dalla mia natura musicale – o umana più che musicale – ma che andavano fatte. Io sono abbastanza convinto che c’è bisogno di essere altro, di diventare altro. Anche le riflessioni sociali sul concetto di identità e di difesa dell’identità che ci sono adesso, sono completamente all’opposto dei miei desideri. Il forzarsi di fare cose che sono fuori da noi ha a che fare anche con un dovere di ricerca che noi imponiamo a noi stessi per ridefinirci in continuazione. Altrimenti parliamo sempre a noi stessi o autoreferenzialmente al nostro circuito.
Nel parlare di Ludica II, in un’intervista del 2013, evidenzi la sfida di scrivere per strumenti molto connotati linguisticamente e con limitato potenziale di fusione. Nel 2019, scrivi Semi alle Bestiole Salve per Azione_Improvvisa, con un organico forse ancor più impegnativo. Puoi parlarci del brano e di come hai affrontato questa sfida?
In Semi alle Bestiole Salve mi sono immaginato una situazione di disinnesco del potenziale linguistico proprio a partire da una dimensione acustica abbastanza particolare, cosa che non avevo fatto, ad esempio, in Ludica II. In Ludica II le parti linguistiche e connotate erano, se vogliamo, esposte. C’era un gioco di attraversamento improvviso di soglie, ma gli aspetti erano abbastanza chiari in termini di massa sonora. In Semi alle Bestiole Salve il trattamento è stato più atomistico. I tre strumenti – la tiorba, la fisarmonica e la chitarra elettrica, oltre all’elettronica che è anch’essa performata on stage con molta voce e molte piccole azioni con strumenti a percussione – sono molto diversi tra loro. Ho cercato di immaginarli letteralmente come degli strumenti bambini, che giocano in un parco, che si sporcano, che si tirano cose, che grugniscono. Questa dimensione da un lato bambina e dall’altro lato animale mi è stata molto utile per disinnescare, a livello di piccole unità, tutto il potenziale linguistico degli strumenti stessi. Di fatto poi il titolo, derivato da un omaggio a Sciarrino, che mi aveva chiesto di scrivere un pezzo ispirato ad un bestiario che mi aveva regalato, ha guidato un poco la scrittura.
Per la tiorba è stato anche abbastanza facile. Ci sono dei momenti in cui ho immaginato la tiorba completamente disposta a terra – di fatto ci sono due placements differenti dello strumento – e quindi chiaramente tutta la pratica tradizionale non c’è. E non c’è nemmeno una pratica tradizionale che mi interessava molto e su cui all’inizio pensavo di lavorare, relativa all’intonazione con lo spostamento dei tasti in ottica microtonale, che però non mi soddisfaceva più di tanto e che ho preferito gestire in ambito elettronico.
Un’altra sfida che hai affrontato recentemente è stata quella di scrivere per chitarra classica, strumento per il quale provavi quasi repulsione. Da cosa era dovuto questo iniziale disinteresse, come hai affrontato la scrittura di Sans Dire e come è cambiato, se è cambiato, il tuo rapporto con lo strumento?
L’iniziale disinteresse nasceva dal fatto che non sono affezionato all’immagine che ho – che è un’immagine falsa per carità, colpevolmente non nobile – della chitarra. Non avevo un affetto per il mondo della chitarra classica e la dimensione concerto classico di chitarra mi ha sempre insospettito dal punto di vista esperienziale. Di fatto, l’ho sempre trovato uno strumento meraviglioso per descrivere la temporalità del ‘momento’ – c’è un che di effimero che mi ha sempre interessato molto nello strumento chitarra.
L’altro motivo che mi allontanava ha a che vedere con l’argomento canzone, nel senso di dispositivo canzone che utilizza la chitarra. Per quanto possa anche essere attratto dalle riflessioni attuali sull’elemento canzone, esteticamente ne sono terribilmente lontano, la rifuggo e molte retoriche legate alla riflessione contemporanea sulla canzone non mi interessano. Per cui il mio rapporto con la chitarra era legato a queste due situazioni. E poi, evidentemente, è uno strumento complesso, non facilissimo da avvicinare. Sembra facile, alle disponibilità di tutti, ma in realtà non lo è, le fasi d’indagine sono complicate, la tecnica è molto particolare e complessa; e l’altra dinamica è quella della potenza. Per cui se avessi dovuto fare un pezzo per chitarra acustica sola avrei detto no.
L’elemento che mi ha poi portato a interessarmi – oltre ovviamente a te, perché se ho un interesse per gli interpreti allora la mia sfida cambia completamente e anche la riflessione sullo strumento – è il fatto che lo strumento fosse amplificato e con l’elettronica. Lì potevo permettermi di sfruttare una palette di suoni esposti con la lente di ingrandimento dell’amplificazione e una drammaturgia un poco differente.
Le sfide sono state tante. Ho voluto fare un pezzo di grandi articolazioni, un pezzo in cui c’è molto non detto, c’è molto gesto. Gesti che volano in aria e che non portano quasi da nessuna parte, delle nuvole, ma che a tratti esplodono.
È stato un lavoro che mi ha ricondotto a una gestualità del rapporto con lo strumento molto vicina a quella di un mio pezzo per pianoforte, Tre Nudi. Un rapporto molto ‘di corpo’ con la chitarra, che non è violata con tecniche estese invasive, è proprio abbracciata. Mi interessava il movimento dell’abbraccio, della mano destra che sale a realizzare i bi-tones; mi interessava molto questa tecnica, il braccio destro alzato che andasse ad inglobare il corpo chitarra. E queste articolazioni che diventano iper-articolazioni con l’aumentazione dell’elettronica, con dei pizzicati che sono una sorta di marimbe fatte di corde attraverso sintesi per modelli fisici. Molto interessante è stato poi il merging con la parte microtonale della chitarra. L’aspetto gestuale esplode con tutta la parte di body action legata alla chitarra stessa, che non mi aspettavo di incontrare ma che invece mi è piombata addosso nel mentre del pezzo e non potevo fare a meno di accoglierla, perché ha proprio dato tridimensionalità a tutto quanto in termini di senso. Non solo l’abbraccio come edulcorante nelle relazioni tra corpi, ma come vera parte affettiva, con delle gestualità che pur non essendo molto chitarristiche, con la chitarra in mano lo diventano.
Nel ricevere Sans Dire ho subito percepito che ci fosse nel brano molto del nostro rapporto, della nostra amicizia. Come se stessi scrivendo a me e non solo per me. Come influenza la tua scrittura la persona o l’ensemble per cui stai scrivendo?
Con gli ensemble ci ho provato diverse volte e ho fallito nei miei tentativi. Per ensemble intendo dal medio ensemble in su, o ensemble con i quali non ho rapporto – di base gli ensemble istituzionali, con i quali c’è un guadagno in termini di crescita e di maturità nel lavorarci insieme ogni tanto, ma di certo non sono il mio interesse principale. Mentre per gli ensemble con i quali collaboro stabilmente, con cui ci sono dei cicli di rapporto, lì nascono delle situazioni differenti. Chiaramente se capita di scrivere un secondo pezzo, come mi è capitato con Nikel, ma anche, ad esempio, con ensemble come mdi, con il quale collaboro da circa vent’anni e con cui, pur non producendo nuovi pezzi, c’è un andare avanti rispetto all’interpretazione della mia musica.
Nei piccoli ensemble e nel solo la situazione è molto diversa, perché lì non mi piace lo ‘scrivere per’, ma appunto ‘portare quelli per cui scrivo a’. Vale a dire, mi piace stare in contatto con gli amici e le persone per cui scrivo durante la scrittura, nel senso che ci penso sempre. Non è più questione di pezzi, è questione di immaginarsi la persona che suona, di scrivere ogni singolo suono immaginandotelo suonato da quella persona. Questo fa sì che, quasi da subito, tu vuoi portare quella persona da qualche parte, che è una cosa differente rispetto ad avere un atteggiamento passivo, come ad esempio quello che la mia generazione poteva avere nello scrivere per il quartetto Arditti, per cui in realtà tu scrivevi per una macchina che ha già delle qualità proprie. Nel lavorare con i soli, e particolarmente con i giovani, a me interessa, da questo punto di vista, costruire un prototipo di motore.
Questo a tratti funziona, a tratti meno, però sempre mi restituisce un rapporto musicale con le persone con le quali collaboro che rimane, indipendentemente da tutto, molto intenso. Penso a te e penso a Matteo Cesari, ad esempio, da cui sono nati due pezzi molto differenti. Matteo Cesari volevo addirittura portarlo letteralmente dove lui non era, e in questo ho sacrificato anche delle cose del pezzo pur di dirgli ‘no, vai lì!’. Nel tuo caso c’è stato un rapporto molto più libero di scoperta dello strumento. Però volevo portare anche te a una consapevolezza performativa di palco e di presenza del focus di ogni azione sullo strumento, che è una cosa estremamente classica, alta, e che richiede un lavoro di concentrazione estremo.
Quando dicevo che questo pezzo ha cominciato a parlarmi di un rapporto carnale e gestuale con il corpo strumento e con l’esteriorità del corpo strumento, della proiezione del gesto del corpo strumento, da lì ho cominciato letteralmente a vederti sempre con il movimento che dovevi fare, e lì volevo portarti – poi non so se ci sono riuscito.
Oltre alla tua attività compositiva, sei anche direttore artistico e musicale di Opificio Sonoro, collettivo musicale con base a Perugia fondato da te, Claudia Giottoli e Filippo Farinelli nel 2019, che oggi conta 14 membri e di cui ho il piacere di essere parte. Cosa ti ha spinto a far nascere questa realtà e cosa rappresenta per te oggi Opificio Sonoro?
Ci sono diverse cose che mi hanno spinto. Innanzitutto la volontà di uscire di casa. Il lavoro della scrittura è estenuante e verso i 40 anni ho cominciato a soffrirlo particolarmente, ad amarlo anche molto di più di prima, però anche a soffrire fisicamente una dinamica di isolamento, perché è un lavoro di estrema solitudine. Un’altra ragione è quella della condivisione, perché ci eravamo accorti che io potevo forse dire qualcosa in termini di direzione musicale o di direzione artistica. C’è anche un aspetto politico se vogliamo, perché mancavano in Italia delle situazioni d’ensemble che rilanciassero il livello qualitativo sia tecnico che interpretativo, e questo mi dava estrema tristezza. Le sfide poi si sono moltiplicate. Il progetto sarebbe potuto finire almeno una decina di volte, però è continuato e farò di tutto per continuare a rilanciarlo e farlo evolvere. In questo momento la mia grande ambizione è quella di disimplicarlo da me, non nel senso di uscita, ma nel senso di libertà, perché non voglio che le altre qualità dell’ensemble vengano mangiate da una percezione esterna limitata alla mia figura, che chiaramente, essendo il direttore musicale e artistico, è oggi abbastanza centrale ed esposta.
Non so cosa ci riserva il futuro, ma la cosa bella è che adesso Opificio Sonoro è una realtà. Negli ultimi due anni è cresciuto in maniera esponenziale, sia l’ensemble in generale, come membri, sia nel lavoro dei singoli, e adesso è una certezza – starà semplicemente agli altri di guardarlo.
Questo è molto bello, vedremo a cosa porterà.
Vuoi svelarci qualcosa dei tuoi progetti futuri? C’è qualcosa con chitarra all’orizzonte?
I progetti futuri per me sono sempre molto facili, nel senso che ne ho sempre pochi. Ho scelto di avere un ritmo di produzione abbastanza lento – l’ultimo pezzo è durato due anni e mezzo di scrittura. Questo comporta che le previsioni di nuovi pezzi siano più lente, nel senso che bisogna riattivare ogni volta, sperando che si riattivi, l’attenzione alla fine di un progetto che ha preso molto tempo, perché nel frattempo ovviamente sono stati negati altri progetti.
Adesso ci sono all’orizzonte due lavori. Uno di questi, che avrà la luce verso aprile 2025, sarà per chitarra elettrica, sassofono ed elettronica.
C’è qualcosa che vorresti condividere con noi, nuova generazione chitarristica?
C’è un giovane movimento che ha a che fare con la chitarra che è estremamente diverso da quello che ho conosciuto io quando avevo la vostra età. Per me questo è del tutto inaspettato e, devo dire a tutti voi, miracoloso, perché è l’inizio di una rivoluzione.
Quello che io spero è che non cediate agli errori di una vecchia generazione chitarristica, che secondo me è stata passiva nel rapporto con i compositori, che ha sempre detto sì a qualsiasi dichiarazione di invenzione, o di ricerca di invenzione. Una disponibilità estrema ma spesso vestita della intoccabile maestria strumentale, l’ossimoro dei regnanti che servono a tavola. Vorrei che foste invece selettivi e poi convinti nel ridefinire voi stessi insieme ad altri, che parlaste del vostro strumento in termini di potenziale artistico piuttosto che di potenziale di ricerca sulle tecniche strumentali – due aspetti che possono essere molto lontani tra loro. Magari suonerete un po’ meno musica contemporanea, ma guadagnerete un repertorio ancora più alto. Per fare questo, dovreste essere liberi, perché il vostro mondo è sempre stato tendente al chiuso (come il mondo della musica contemporanea) e ci sono state anche delle figure che lo hanno molto spesso vincolato e hanno cercato di monopolizzarlo. Mi riferisco in particolar modo al mondo della chitarra elettrica, che invece adesso finalmente respira e deve mantenere questo approccio del tutto iconoclasta.
Da un lato dare priorità ai contenuti piuttosto che al pezzo per strumento, cioè rendere lo strumento un veicolo per un contenuto e non uno specchio per una presunzione di invenzione, e dall’altro l’iconoclastia, permettersi di farsi gli affari propri, di dire no e di fare le proprie scommesse. Questo vi garantirebbe una libertà, una freschezza, e finalmente aprirebbe il vostro strumento al grande repertorio classico, non solo contemporaneo, facendolo uscire dalla dinamica di genere. Adesso si inizia a poter ragionare in questi termini attraverso di voi, quindi spero possiate insistere nella vostra rivoluzione.

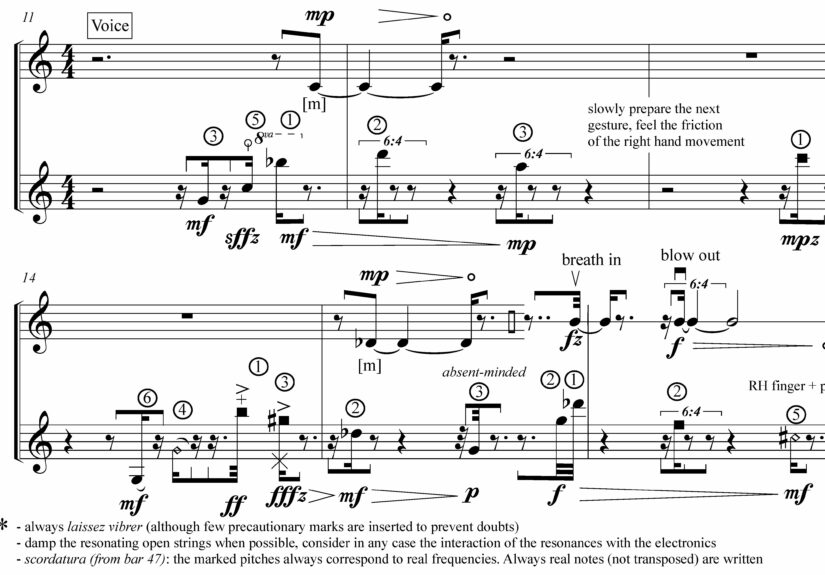

bellissima intervista come tutti i vostri articoli!